Cultura
LEGGERE E' BELLO E POSSIBILE. PER MARINO SINIBALDI IL LIBRO DEVE USCIRE DAI SOLITI CIRCUITI
Intervista al vicedirettore di Radio Rai, nonché ideatore, nel 1999, del fortunato programma culturale pomeridiano "Fahrenheit": propongo di banalizzare il libro e di portarlo dappertutto e in qualsiasi contesto, dice. Non si può capire cosa succede al mondo senza provare in prima persona le forti emozioni provocate dalla lettura
18 novembre 2006 | Antonella Casilli
Abbiamo incontrato Marino Sinibaldi al terzo forum del libro e della promozione della lettura, svoltosi a Bari su iniziativa di Giuseppe Laterza.
Passaparola è lo slogan del forum ma poi di passaparola vi è ben poco, sembra che tanti più che altro vogliano far leggere gli altri ed allora come fa a trasmettersi l’entusiasmo per una bella lettura?
Forse quello che dirò dipende dal fatto che lavoro nel mezzo di comunicazione più leggero ed agile, il più amichevole e vicino ai destinatari - fino ad apparire qualcosa di felicemente scontato – come è o dovrebbe essere, la radio. Ma penso che o il libro esce dalle sue nobili cittadelle fisiche e simboliche, e diventa in qualche modo e con qualsiasi mezzo un oggetto scontato e banale, o saremo condannati a confrontarci all’infinito con cifre desolanti e previsioni scoraggianti.
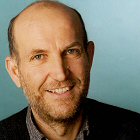
Lei a tal proposito cosa propone?
Non solo provocatoriamente, propongo di lavorare per banalizzare il libro e la sua presenza nella vita quotidiana degli italiani.
A suo tempo, per esempio, il Presidente Ciampi, aveva rivolto un singolare ma inscoltato appello, “mettete nelle mani dei vostri personaggi qualche libro in più!â€. E in effetti: perché non c’è mai uno che legge, perché non compare mai un libro nelle infinite scene di serial, di soap, spot, telefilm, sitcom?
Oddio, mi faccia capire, secondo lei dovrebbero sembrare lettori i concorrenti del Grande fratello, i protagonisti dei vari Beautifull, la famiglia Adams?
Dobbiamo rallegrarci al pensiero che il libro stia alla larga da un universo simile , ma il prezzo che il libro paga per questa sua felice secessione è quello di apparire un oggetto elitario e appartato, raffinato ma estraneo. Cosa che il libro non è! Banalizzare i libri e la lettura significa innanzitutto affermare e dimostrare che qualsiasi vita non ne può fare a meno.
Sa, io un concorrente del grande fratello lettore lo immaginerei vincente!
Le tensioni globali che si rovesciano sulla vita quotidiana, l’incertezza e lo smarrimento chiedono letture possibili. Non si può capire cosa succede al mondo, se non se ne traggono emozioni e informazioni sufficienti senza lettura. Idea altissima del libro e della lettura, dunque : e infatti la banalità del libro propugno non è bassa e volgare ma alta e del tutto singolare. Non è un’affermazione scontata. Registra infatti la precoce ma non solo provvisoria delusione provocata dalla promessa di altri media di poter sostituire o limitare la necessità dei libri. Sono ormai passati tanti più di dieci anni da quando, in una bella Storia della letteratura, Armando Petrucci sottolineava che “diversamente dal passato, oggi la lettura non è più il principale strumento di acculturazione†e quello che è successo nel frattempo (la planetarizzazione di Internet) la portata dell’affermazione.
I suoi programmi come il nostro giornale, invece, direi che sono strumenti di acculturazione che strizzano l’occhio al padre di tutte le culture.
L’emozione dalle guerre da allora scoppiate, dal terrorismo globale, dallo scontro dei fondamentalismi sono drammaticamente incomplete senza i libri. Tutto quello che è circolato in questi mesi, tra giornali, telegiornali, siti web e blog è insufficiente – questo posso dirlo a partire dal mio lavoro quotidiano - senza i libri di Barber, Kepel, Walzer, o Beck. Nel mio lavoro questo ha significato considerare i libri qualcosa di banalmente necessario per capire alcune cose capitali (ma anche alcune meno essenziali), trovare il modo di inserirli, citarli, utilizzarli in ogni dibattito, farvi continuamente riferimento.
Un consiglio?
Far stare i libri dentro le cose, non fuori dal mondo.
Del resto i libri devono essere leggeri e banali anzitutto per la loro natura materiale, per la semplicità con cui possono essere spostati, usati, attivati.
Come pensa di poter conciliare la banalità quotidiana con una giusta e meritata trascendenza?
Nel mio lavoro radiofonico c’è qualche esperienza che va in questa direzione e che può essere utile riferire. Anche perché mi sembra che si inserisca in un processo più ampio che sta trasformando il mondo del libro e della lettura. Se non le sue quantità (in effetti quasi immobili), la sua qualità . Si pensi ai festival letterari, ai reading, ai forum sul web: tutti luoghi il cui successo sembra contraddire altri dati meno positivi. Ma la contraddizione si scioglie se si considera che in questi luoghi la comunità dei lettori fa qualcosa di molto ovvio per ogni altra comunità o minoranza: incontra e in qualche modo esibisce se stessa.
Senza frivolezza, ma con l’orgoglio che hanno da tempo altre minoranze in un mondo dove ogni tribù ha diritto di cittadinanza. Così ai lettori italiani in questi anni è capitato di perdere un po’ della propria altera eccezionalità , quella sorta di mistero che ha circondato l’invisibilità di chi legge, ma di conquistare visibilità e autoriconoscimento.
Non c’è pericolo che così il libro si spettacolarizzi?
Avendo seguito con le trasmissioni di Radio 3 questi fenomeni, il tratto più significativo mi è sembrato la felicità di condividere in pubblico qualcosa che si è abituati a considerare individuale e segreto. Trasformarlo in qualcosa di ovvio, normale, quasi banale appunto. E’ del resto quello che cerchiamo di fare ogni giorno con i nostri programmi offrendo spazio alla conversazione seria intorno al libro e alla lettura, ma anche proponendo forme diverse, più leggere e al limite giocose. La più nota è probabilmente il bookcrossing.
Lasciare il libro in giro?
La gran parte delle persone che vi hanno preso parte lasciando i loro libri preferiti in giro per l’Italia, per esempi, ha manifestato una istintiva predilezione verso luoghi banali e quotidiani (anzi, per essere onesti, una ancor più suggestiva ma non credo contraddittoria divaricazione, scegliendo o luoghi altamente simbolici – le scale di casa Svevo, l’emporio del paese dove sfollo Gadda – oppure fortemente banali: le panchine, le sale d’attesa, i bancomat).
La cosa, al riguardo, più interessante è che da un lato il libro è stato affidato a una inedita quotidianità , una sorta di secolarizzazione; dall’altro proprio la sua apparizione in contesti sorprendenti ha alimentato una sorta di magia che lo circonda. Chi vi si imbatte è tanto più colpito se è un non lettore : non avrebbe mai pensato che un libro gli si potesse così tanto avvicinare. E si sente sfidato:non so se a diventare un lettore; sicuramente a guardare con meno diffidenza e distanza un oggetto così semplice e banale. La prova che il libro non perdere nulla della sua singolare magia se diventa più visibile e accessibile.
A questo punto, nel salutare, normalmente chiediamo il libro sul comodino, dopo aver parlato di bookcrossing sorge spontanea la curiosità di sapere qual è il libro che lei lascerebbe in giro per cooptare nuovi lettori, quello che le è più caro da sempre, per intenderci…
Beh, il libro "di sempre" per me è il Don Chisciotte, ma mi rendo conto che può apparire troppo impegnativo, se non altro per la mole. E allora sceglierei un racconto: di Cecov, di Carter o di Elsa Morante.




